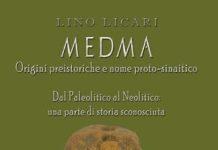Terremoto del 1626: dopo 399 anni la terra continua a tremare nel catanzarese
Il 4 aprile 1626, la regione del Catanzarese, in Calabria, fu scossa da un potente terremoto, noto come il terremoto di Girifalco. Questo evento sismico ebbe conseguenze devastanti per le comunità locali, causando numerose vittime e ingenti danni alle infrastrutture. Nel XVII secolo, la Calabria era una regione del Regno di Napoli caratterizzata da una società prevalentemente agricola, con centri urbani come Catanzaro e Girifalco che fungevano da poli amministrativi e commerciali. La posizione geografica della Calabria, situata tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio, la rende particolarmente vulnerabile all’attività sismica a causa della complessa interazione tra le placche tettoniche africana ed eurasiatica.
Il terremoto principale si verificò alle 12:45, con una magnitudo stimata di 6.0 Mₑ e un’intensità massima percepita di X (Estrema) sulla scala Mercalli Modificata. L’epicentro fu localizzato nelle vicinanze di Girifalco. Questo evento fu il più forte di una sequenza sismica che durò dal 27 marzo fino a ottobre dello stesso anno.
Le città di Girifalco e Catanzaro subirono i danni più gravi. A Girifalco, molte strutture furono completamente distrutte, mentre a Catanzaro si registrarono crolli significativi di edifici pubblici e privati. Il numero esatto di vittime non è noto. Le infrastrutture, inclusi ponti e strade, furono gravemente danneggiate, isolando ulteriormente le comunità colpite.
Il terremoto è stato attribuito al movimento del sistema di faglie Stalettì-Squillace-Maida, una struttura tettonica con orientamento nord-ovest/sud-est. Questa faglia è parte di una rete di discontinuità geologiche che attraversano la Calabria, rendendo la regione particolarmente suscettibile a eventi sismici di elevata magnitudo.
Oltre alla perdita immediata di vite umane e alla distruzione di proprietà, il terremoto del 1626 ebbe ripercussioni durature sulla regione. L’economia locale, basata principalmente sull’agricoltura e sull’artigianato, subì un duro colpo a causa della distruzione che colpì quelle terre. La ricostruzione fu lenta e costosa, aggravata dalla mancanza di risorse e dalla difficoltà di accesso alle aree colpite.
Questo evento ha evidenziato la necessità di una pianificazione urbana che tenga conto della sismicità del territorio. Nel corso dei secoli, la Calabria ha adottato normative edilizie più rigorose e ha implementato sistemi di monitoraggio sismico per mitigare gli effetti di futuri terremoti. Tuttavia, la memoria storica di eventi come quello del 1626 rimane fondamentale per comprendere l’importanza della preparazione e della resilienza comunitaria.
Il terremoto del 4 aprile 1626 nel Catanzarese rappresenta uno degli eventi sismici più significativi nella storia della Calabria. Analizzando le cause, gli effetti e le risposte a questo disastro, possiamo trarre insegnamenti preziosi per la gestione del rischio sismico nelle regioni vulnerabili. La consapevolezza storica e l’adozione di misure preventive restano strumenti essenziali per proteggere le comunità da future calamità naturali.